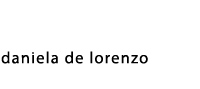Bellezza vaga
Villa Mansi
Segromigno in Monte, Lucca.
Testo di Sergio Vitale
Show
Comincerò col dire che in nessun modo, per quanto fortemente si sia propensi a farlo, la bellezza può essere detta propriamente. Sembrerebbe questo il modo peggiore per iniziare (e concludere al tempo stesso) il discorso, decretandone in egual misura l’impossibilità e l’inutilità. Ma quello che vorrei fin da subito mettere in chiaro è che ritengo non abbia alcun senso credere di poter definire una volta per tutte che cosa sia la bellezza in sé, ovvero di poter afferrare ciò che ne costituisce l’intima essenza. Questo non significa che, se non si può dire la bellezza, non si possa per altro verso parlare della bellezza, ossia parlare intorno ad essa: è ciò che in realtà abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare sempre, e il mio discorso non costituirà un’eccezione. Non si tratta certo di una posizione eccentrica o particolarmente bizzarra. Platone, nel Cratilo, ha (per bocca di Socrate) affermato che la bellezza trova modo di esprimersi in mille maniere diverse nel solo istante in cui cerchiamo di conoscerla, variando in continuazione; e dunque come potremmo parlare di vera conoscenza se, avvicinandoci alla bellezza nell’intento di fissarla, essa è già altra rispetto a quanto era prima?
Oppure, facciamo riferimento a Cesare Ripa, l’autore della Iconologia, il più celebre testo sull’allegoria tra i secoli XVI e XVII, il quale ha descritto la bellezza come «una donna che abbia ascosa la testa fra le nuvole, e il resto sia poco visibile, per lo splendore che la circonda», e questa impenetrabilità allo sguardo è giustificata dal fatto che «non è cosa della quale più difficilmente si possa parlare con mortal lingua, e che meno si possa conoscere con l’intelletto umano».
E allora quello che è nelle nostre possibilità è riconoscere la bellezza unicamente dal suo passaggio, nelle cose che riflettono la sua luce; o meglio ancora: riconoscerla dagli effetti che il suo transito è in grado di produrre. Perché la bellezza vaga dappertutto, la possiamo incontrare ovunque – e dicendo così diamo un primo significato al titolo di questa giornata: bellezza vaga, nel senso di bellezza nomade, in continuo movimento. La bellezza è senza fissa dimora, ma sta a noi avere occhi per guardarla, orecchie per ascoltare la sua voce, mani per poterla sfiorare…; in una parola: sta a noi approntare una mente entro cui accoglierla.
La possiamo incontrare ovunque, ho detto, anche nelle cose cha appaiono di poco conto, quelle che l’abitudine e la ripetizione rendono opache alla nostra percezione. Prendiamo queste parole di Knut Hamsun, scrittore norvegese (Nobel per la letteratura nel 1920), tratte dal suo romanzo Pan: «Pensate. A volte vedo la mosca azzurra. Già, sembrano cose da poco, non so se capite […] E a volte guardo l’erba, e magari l’erba guarda me, che ne sappiamo? Guardo un singolo filo d’erba, forse tremola un poco, e a me sembra qualcosa d’importante. Penso tra me: Ecco un filo d’erba che tremola! E se invece è un pino che sto osservando, può darsi che abbia un ramo che mi spinge a dedicargli un pensiero […] Caddero le prime gocce di pioggia. Piove, dissi allora. Pensa, piove, disse a sua volta, e già se ne stava andando».
Ebbene, non è forse anche qui la bellezza, nella mosca azzurra, nel filo d’erba, nella goccia di pioggia? Anzi, qui è presente due volte: nelle cose minime che spesso ci circondano e a cui non prestiamo più attenzione; e nelle parole di Hamsun, che lasciano affiorare il mistero dell’esistenza e ci inducono a riflettere. La bellezza delle parole, nella loro semplicità, ci fa ricercare la bellezza che emana dal volto delle cose, anche le più banali. E allora, potremmo dire, è così che accade: la bellezza dell’arte ci pone sulle tracce della bellezza vaga, che nella sua erranza può gettare ovunque la sua luce. E tale bellezza è vaga anche in un secondo senso, quello inteso da Kant: pulchritudo vaga, non assoggettata ad alcuno interesse particolare e ad alcuna funzione pratica, ma – per questa sua libertà – assolutamente necessaria. Vaga è la bellezza dell’arte, che va sempre oltre qualsiasi intenzione deliberata, come vaga è quella del filo d’erba e della nuvola.
E allora, se non possiamo dire la bellezza, che cosa possiamo dire intorno ad essa, a partire dalla sua vaghezza? Senza avere alcuna presunzione di offrire un quadro completo, vorrei dare al mio discorso un tono per così dire prescrittivo, cercando di individuare quattro requisiti che devono essere soddisfatti perché si possa parlare della bellezza o, se preferite, del suo passaggio; e cioè: 1) deve produrre ritardo; 2) deve destare pensieri randagi; 3) deve unire gli opposti; 4) deve contenere l’invisibile. Quattro requisiti da non considerare separatamente, ma che si sorreggono e si consolidano reciprocamente.
È bene ribadire che l’opera d’arte ci mette sempre sulle tracce di qualcosa che non si lascia prontamente afferrare in maniera chiara. Emerge così quel il primo tratto caratterizzante la bellezza dell’opera d’arte: deve produrre ritardo. Il corso spedito e disinvolto del pensieri, secondo cui tutto è sotto controllo e tendenzialmente in ordine, deve subire un inciampo, tale da far cadere l’illusione di arrivare ogni volta puntuali alla meta. Qualcosa ci attarda lungo il cammino, richiede un supplemento di pensiero, ci costringe a tornare sui nostri passi. La bellezza dell’opera d’arte è nemica della linea retta, che è la linea più veloce e arrogante, nella sua pretesa di non subire alcuna deviazione o contrattempo, e sembra elargire nella sua decantata rettitudine una promessa di felicità. La bellezza sta invece dalla parte del curvilineo, della linea che non punta dritto da nessuna parte, e trova nella sua erranza il motivo della sua stessa ricchezza. È necessario fermarsi, perché l’opera sembra sul punto di dire qualcosa, la stessa cosa che però non si dice mai completamente, e che nel tentativo di comprendere ci impedisce di procedere oltre. Che cos’è la profondità di un’opera se non il tempo che essa impone per un lungo seguito di pensieri? La profondità, metafora spaziale, forse non è altro – come ha scritto Vladimir Jankélévitch – che «quell’immenso avvenire di riflessioni e perplessità» racchiuso in una macchia di colore, in un suono, o in un giro di parole.
Veniamo così al secondo tratto che consente di cogliere il passaggio della bellezza: essa deve suscitare pensieri randagi. Sono pensieri che non si integrano immediatamente nel sistema dei pensieri (già pensati) propri del soggetto, e che invece potrebbero essere definiti pensieri senza pensatore. Pensieri selvatici da addomesticare, come quelli che si fanno incontro nel sogno: se decidiamo di farli diventare una nostra parte costitutiva, dobbiamo intrattenerci a lungo con loro, e alla fine ci sveleranno sempre qualcosa che non conoscevamo. A volte sono pensieri che vengono da chi sa dove, senza una genealogia che consenta di ricostruirne la precisa discendenza; altre volte sono pensieri che recano il nome o perfino l’indirizzo del possessore, e ciò non di meno risultano del tutto estranei e perturbanti. Possono essere pensieri che l’artista, all’insaputa di se stesso, ha consegnato alla sua opera, i quali hanno vagato sino a noi per comunicarci qualcosa che non sapevamo, o non volevamo sapere sino in fondo. Le parole di Pasternak ad esempio: “Tu sei ancora qui,/ e mi hanno detto ove sei adesso / e ove sarai alle cinque. / Io ti potrei trovare nel Kursaal / piuttosto che ciarlare invano. / Tu ascolteresti, ritornando giovane, / grande, libera, audace, / dell’uomo giunto al limite / da una formica che è cresciuta troppo”. Oppure i colori della cattedrale di Rouen, ritratta oltre cinquanta volte sulla tela da Monet; o il suono arcano della tromba che si ripete ne La domanda senza risposta di Charles Ives (1906). E accade che un pensiero randagio, se bene accolto, non sia mai solo: si porta dietro uno stuolo di altri pensieri mai pensati che vogliono trovare una casa, la quale potrebbe essere quella di ciascuno di noi, dal momento che il passaggio della bellezza arriva a produrre anche questo.
E ancora: essa deve unire gli opposti. Con questo intendo allontanarmi dall’idea della bellezza intesa come armonia e pacificazione prive di qualsiasi tensione conflittuale. Piuttosto, bellezza come manifestazione visibile dei contraddittori, come scandalo, direbbe Simone Weil, «che si impone e che colma di gioia». La contraddizione è ciò di cui solitamente il nostro pensiero tenta di liberarsi, focalizzandosi sull’uno o l’altro dei contrari, separatamente. Il bianco o il nero; l’innocente o il colpevole. Mai i due insieme, presi nella loro contraddizione irriducibile, e dunque mai «la possibilità di vedere attraverso l’innocente il colpevole e attraverso il bianco il nero», come invece si propone di fare chi, come Odisseas Elitis, considera il proprio lavoro di poeta il solo modo per dare all’ignoto la parte che gli spetta. È compito dell’arte, visitata dalla bellezza, indirizzarci lungo questa strada, per quanto difficile possa essere: unire in un pensiero solo pensieri che pensano separatamente. Vorrei fare riferimento, cercando di essere più chiaro, a una coppia di contrari, forse la coppia madre di tutte le opposizioni: Terra e Mondo. Due termini che il linguaggio ordinario considera equivalenti e intercambiabili, ma che in realtà sono insanabilmente diversi. La Terra è il grembo che ci ha accolto, fondamento in sé innocente, né buono né cattivo, se non agli occhi di chi la abita, di noi che su di essa, spesso anche contro di essa, abbiamo costruito il Mondo, quest’ultimo sì, privo di innocenza, sempre orientato in vista di un fine, di un calcolo o di un interesse. Ebbene, Terra e Mondo devono ritrovarsi nell’opera d’arte; o meglio, l’opera d’arte deve contenere nel fondo di se stessa la memoria del conflitto che li separa e al tempo stesso li unisce indissolubilmente. Non si tratta di una lotta dalla quale debba uscire un solo vincitore, né tanto meno di un pacifico accomodamento. Piuttosto, nella contesa che permane, i contendenti si esaltano reciprocamente, elevandosi l’uno sull’altro, l’uno attraverso l’altro. Martin Heidegger, scrivendo dell’Origine dell’opera d’arte, ha detto che «ciò in cui l’opera si ritira e ciò che, in questo ritirarsi, essa lascia emergere lo chiamiamo: la Terra […] Su di essa ed in essa l’uomo storico fonda il suo abitare il mondo. Esponendo un mondo, l’opera pone-qui la Terra». Si prenda il quadro di van Gogh Un paio di scarpe (1886): per un verso queste scarpe rappresentano il mondo della contadina, in cui le scarpe sono un mezzo da indossare, senza alcuna riflessione particolare (come facciamo tutti noi), per affrontare il lavoro di tutti i giorni; per altro verso, attraverso queste scarpe – svincolate dal loro essere semplicemente un mezzo – «passa il silenzioso richiamo della terra, il suo tacito dono di messe mature e il suo oscuro rifiuto nell’abbandono invernale […] Questo mezzo appartiene alla terra e il mondo della contadina lo custodisce».
Vorrei riprendere questa unione degli opposti da un altro punto di vista, parlando di spazio liscio e di spazio striato: espressioni che derivo da Gilles Deleuze e Felix Guattari, e che proverei a sostituire alla coppia Terra- Mondo. È indubbio che tutte le operazioni che vengono poste in atto per progettare e costruire il Mondo equivalgano ad altrettante modalità per incidere la superficie della Terra, per lasciare una traccia durevole della nostra presenza e attestare al contempo la forza e le capacità che ci contraddistinguono. Lo spazio striato è uno spazio diventato di nostra appartenenza, in cui ci riconosciamo e in cui, grazie al gioco delle striature, possiamo orientarci – cose entrambe fondamentali per la sopravvivenza: sapere chi siamo e dove siamo. Al contrario, lo spazio liscio è lo spazio anteriore a qualsiasi intervento umano, o che nella sua indifferenza resiste ad ogni tentativo di striatura: si pensi alle acque dell’oceano o alla sabbia dei deserti, e alla rapidità con cui la traccia del passaggio si dissolve nel nulla. E dunque, il liscio e lo striato devono a loro volta trovarsi in tensione nell’opera d’arte, in un rapporto dinamico e perpetuamente instabile. Di contro alle striature che la mano viene realizzando – sulla tela o nella pietra – deve attestarsi il liscio, lo spazio vuoto e inespugnabile, dove tutto sparisce, come lo spazio bianco che sulla pagina divide un segno dall’altro, senza il quale il senso stesso delle parole sarebbe perduto per sempre.
E vengo così all’ultimo punto: deve accogliere l’invisibile. Qui vorrei parlare, sia pure in breve, dell’inotticità della bellezza; affermare, cioè, che la bellezza non è unicamente un’esperienza retinica, fatta solo per gli occhi e con gli occhi, ma è anche, se non soprattutto, una anti-visione, qualcosa che nasce contro l’occhio, come elusione dell’ottica. Questo implica fondamentalmente due cose. La prima è che l’opera d’arte deve contenere l’invisibile non come una sua parte accidentale o accessoria, bensì costitutiva. L’opera significa tanto per quello che si vede, quanto per quello che, pur essendo contenuto al suo interno, non si vede. Non dobbiamo pensare soltanto alla musica, e all’invisibilità dei suoni che la compongono, ma anche ad un arte che si ritiene esclusivamente visiva come la pittura. Prendiamo Las Meninas di Diego Velazquez (1656): come il quadro ci mostra, vi è grande tela che il pittore sta dipingendo, della quale scorgiamo solo il rovescio, così che il suo contenuto rimarrà per sempre al di fuori della portata dello sguardo. Cionondimeno, tale contenuto invisibile entra a far parte del quadro che stiamo guardando: che cosa rappresenta? è forse il quadro stesso che è dinanzi a noi, che dunque a sua volta contiene una parte che si nega alla visione, e così all’infinito, in una sorta di messa in abisso? Oppure facciamo riferimento al Grande vetro di Marcel Duchamp (1912-1923), sul quale avremo modo di ritornare più avanti. Ci sono le figure visibili: la Sposa, la Via Lattea e i tre pistoni di corrente d’aria, e poi i nove stampi malici, la macinatrice di cioccolata ecc. ecc. Ma oltre a tutto questo, c’è (perché ce lo ha detto lo stesso Duchamp) quello che non vediamo e che rimarrà ostinatamente invisibile, pur possedendo la stessa consistenza ontologica del visibile: i nove spari, il treppiedi, la molla e la piattaforma del giocoliere-manovratore-sorvegliante di gravità, gli Arieti dell’Incontro di pugilato, e così via. E poi ancora: L’oggetto invisibile di Alberto Giacometti (1934), dove l’allusione a quello che è invisibilmente presente al nostro sguardo diviene esplicita, al punto da costituire il titolo stesso dell’opera. E infine (ma questa galleria potrebbe allungarsi ancora molto): An Oak tree di Michael Craig-Martin (1973): ciò che ci sembra di vedere è un bicchiere d’acqua su di una mensola, ma in vero si tratta, come recita il titolo dell’opera, di una quercia secolare, o meglio ancora di un bicchiere d‘acqua che l’intervento dell’artista ha trasmutato in un vecchio albero di quercia senza modificare le sembianze del bicchiere. L’artista non può provare in maniera inconfutabile che le cose stiano veramente così, ma egli è sicuro, dopo anni di applicazione, di essere riuscito a mutare senza alcuno sforzo la sostanza fisica di un bicchiere d’acqua in quella di un albero di quercia. Parte integrante dell’opera è una tavola, affissa sul muro al di sotto della mensola, dove è riportato un dialogo in cui l’artista spiega ad un ipotetico interlocutore come vedere correttamente l’opera: senza le sue parole chiarificatrici noi finiremmo per scambiare, fidandoci della mera apparenza, una quercia maestosa per un modesto bicchiere su di un ripiano.
Quest’opera di ci avvicina al secondo punto implicato dall’inotticità della bellezza, e alcune parole di Duchamp, riferite al Grande Vetro, ci aiuteranno ad inquadrarlo nel modo più diretto. Insistendo sul valore “antiretinico” da attribuire all’arte, Duchamp ha sottolineato l’esigenza di accompagnare la visione della sua opera con una sorta di volumetto d’istruzioni, in modo da poter guardare il Grande Vetro non secondo il tradizionale senso estetico: «Bisognava consultare il libro e vederli insieme» egli dice. Proprio come bisogna consultare la tavola posta da Craig-Martin sotto An Oak tree e vederli insieme. Il passaggio che si compie in tal modo è da una bellezza visibile, che si affida alla forma, alla linea, al colore, ad una bellezza invisibile, non retinica, diciamo puramente mentale: la bellezza del concetto. L’arte del Novecento ci ha dato numerose testimonianze, forse come mai era avvenuto in passato, riguardo questa bellezza invisibile, che non passa attraverso nessuna percezione sensibile, ma è egualmente capace di produrre ritardo, di suscitare pensieri randagi, di unire gli opposti.
I punti che ho preso in esame ci avvertono dunque del transito della bellezza e della sua presenza nell’opera d’arte. Credo che ciascuno di voi potrà ritrovarli e averne esperienza diretta vedendo le opere di Daniela De Lorenzo, che sono qui esposte negli spazi di Villa Mansi. Non voglio anticiparvi nessuna immagine, perché sarà la stessa artista a guidarci tra non molto nella presentazione delle diverse opere. Tuttavia, vorrei citare alcuni lavori, che ai miei occhi hanno fornito una significativa conferma delle idee che questa mattina ho cercato di esporvi. Le teste che compaiono sotto il titolo Contrattempi, ad esempio. Sono volti che si vedono solo in parte e in maniera molto sfuggente. La parte visibile, in cui risiede solitamente l’attestazione di un’identità e la possibilità del riconoscimento di qualcosa o di qualcuno, si disfa nel suo contrario, si cancella in un margine vuoto dove fa naufragio ogni certezza e ogni proposito di un riconoscimento fermo e rassicurante. L’identità (la mia come quella di altri), che il Mondo con le sue pratiche e i suoi rituali si impegna a certificare ed esibire, svanisce nel suo volgersi dall’altra parte, la parte della Terra, la quale smaschera qualsiasi falso privilegio di altezza che siamo soliti attribuirci. Oppure penso a opere come Escamotage o Pantomima, in cui il materiale impiegato è il feltro. Come non tenere conto di quanto Deleuze e Guattari hanno detto a proposito della particolarità di questo anti-tessuto, che – nel sottrarsi al gioco ordinato di striature della trama e dell’ordito – costituisce, nel suo groviglio di fibre aperto e illimitato in tutte le direzioni, uno spazio liscio, senza rovescio, né dritto, né centro, ed è al tempo stesso il materiale preferito dalle popolazioni nomadi, splendido isolante di cui son fatte le tende, e si connette direttamente (al contrario del tessuto-indumento e del tessuto-arredamento legati alla casa e alla vita sedentaria) allo spazio del fuori, allo spazio liscio e aperto, dove il corpo è in movimento continuo. Molti dei lavori di Daniela De Lorenzo mi sembrano insistere sulla fragilità ma anche sulla bellezza profonda dello spazio liscio, così come traspare dal nostro stesso corpo nel suo emergere dalla Terra. Le striature che lo attraversano, e che potrebbero avere la parvenza di una solida struttura, hanno in realtà la stessa consistenza delle impronte lasciate nel deserto, o delle onde che increspano l’oceano. Quasi un ricamo di estrema delicatezza, appena affiorante dalla superficie, che opere come Indizi e Scansione sembrano suggerire, nel ripetere il tenue disegno delle vene che irrorano la vita, oppure la scia esitante che lo sguardo deposita sulla realtà in cerca di qualcosa.
Ma qui mi fermo, per lasciare spazio al flusso di altri pensieri vagabondi, ancora più vivi e veementi, forse anche perturbanti, che chiederanno di essere accolti e diventare parte di noi, quando tra poco incontreremo la bellezza che vaga per queste stanze e le riempie della sua luce.
Sergio Vitale